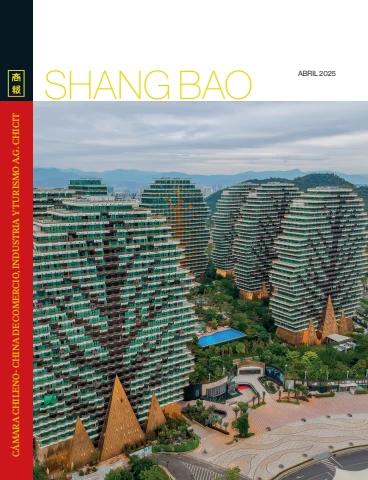Cara Signorina...
FAUSTO FASSER, LETTERE 1958 - 1959
La volontà di raccogliere in questo piccolo libretto una selezione di ottanta buste tra le molte altre che Fausto scrisse, ed in particolare
queste inviate tra il 1958 e il 1959, non deriva solamente dalla mia evidente, straripante stima nei suoi confronti.
Non un esercizio nostalgico, non un compiacersi di ciò che fu.
No, nella mia vita mi hanno insegnato ed ho imparato a dare valore a ciò che è bello. A non nascondere una lampada sotto ad un secchio,
a non conservare gelosamente ciò che si riceve o si possiede.
Scoperto di avere un tesoro, anche un piccolo tesoro farne parte agli altri, condividerlo, sempre.
Approfitto quindi di questa bella occasione in cui si ha l’abitudine di scambiarsi regali, per fare dono di ciò che diversamente sarebbe
rimasto in un cassetto.
Filippo
25 dicembre 2019
Una busta è un guscio. Uno scrigno per qualcosa di prezioso. Una protezione da sguardi indiscreti. Una busta è come un soprabito per
un bel vestito che non deve macchiarsi. È anche una barriera che tiene fuori la comunità dallo scambio tra due persone in dialogo privato.
Per uno studente di 25 anni che si scioglie al sole di luglio, odiando i manuali degli esami incombenti e sospirando al pensiero della sua
ragazza volata in Scozia come ragazza alla pari, la busta diventa una tavolozza di sperimentazioni: dalla pagina delle lettere alla sua amata
tracimano i sentimenti, che scoppiano e sbocciano, le sue ansie da universitario, la passione per la grafica. I fogli piegati in tre parti non
bastano a contenerlo. È come se la sua calligrafia e le sue illustrazioni fossero fiumi in piena, tanto da far crollare gli argini dell’etichetta
epistolare. Qualcosa che è solo “mio e tuo” si riversa in totale libertà sulle due facciate della busta, impregnandola di palpiti d’amore e
guizzi umoristici.
Siamo a fine anni Cinquanta, un’epoca lontana: mancano 35 anni alla nascita del fondatore di Facebook Mark Zuckerberg, Steve Jobs e Bill
Gates sono ancora bambini che imparano a parlare prima di programmare. Con un salto all’indietro di tre generazioni troviamo il giovane
Fausto Fasser che dà forma, in abissale anticipo sui tempi, all’ideale bacheca cartacea di un social network.
Nel 1958 l’involucro delle lettere, accompagnate da timbro e francobollo, diventa uno schermo, una vetrina dell’inquieta voglia di vita di un
ragazzo del 1933. Il suo network, la rete dei suoi contatti, è fatta di fratelli, amici, professori, fidanzata, postini e vicini di casa.
A qualcuno parrà irriverente accostare la raffinatezza delle trovate del bresciano artista-ingegnere (un ossimoro?) alla sciatteria del
quotidiano che il mondo digitale ci propina: eppure condivisione è la parola magica. Si può svilirne il senso costruendo un profilo di sé
egotico, auto-referenziale, aggressivo, superficiale, fingendo di condividere “emozioni” con altri di cui neppur ci si cura oppure si può,
giorno dopo giorno, cogliere la reale portata del verbo che in francese si traduce partager e in inglese to share.
Significa che ognuno partecipa di qualcosa che viene diviso ma significa anche “offrire del proprio agli altri”. Proprio quello che ha fatto nei
suoi 74 anni di vita Fausto Fasser, costruttore che fin da bambino coltivò il divertimento per il disegno, passione ereditata dal padre assieme
ai fratelli: primo dei cinque figli di Giovanni Fasser e Maria Gadola, alla fine degli anni ’50 frequentò l’università al Politecnico a Milano
e a Genova, per poi partire per il servizio militare a Torino. In quegli anni nutrì una simpatia e poi l’amore per quella che sarà sua moglie,
Nicoletta Seassaro.
Esiste ancora qualcuno che snobba fumetti e illustrazioni satiriche ponendoli al rango basso della scala verso la conoscenza? Ma se pure
l’inglese Edward Lear nella prima metà dell’Ottocento, richiesto come maestro di pittura dalla regina Vittoria, trovò il sollievo più puro dalle
ipocrisie dell’abitudine creando vignette spassose e malinconici “limerick” – componimenti basati su disegni e filastrocche, all’insegna del
nonsense –, in cui metteva alla berlina tutti, anche se stesso? Per non parlare del reverendo Charles Dodgson, in arte Lewis Carroll, le cui
invenzioni non serve qui rispolverare nel dettaglio.
La studiosa Elizabeth Sewell tra le prime ci ha avvertito: il nonsense non è irrazionalità a briglia sciolta, è un gioco con una sua struttura
ludica ben piantata, tanto più coinvolgente quando più raffinati sono i cortocircuiti e i raccordi della mente logica che li illustra. La realtà
slitta su un altro binario, come nei disegni di Fasser: ma così facendo il treno della creatività scivola su un percorso altrettanto reale, quello
del mondo visto con gli occhi di un sognatore, di un utopista. Gli occhi e le mani del vero homo faber, dunque.
Possiamo qui gettarci con piacere alla rincorsa delle analogie e dei modelli, conoscendo l’attrazione dell’autore per Jacovitti e Steinberg
(“Siamo tutti figli di Saul Steinberg”, lo diceva anche Copi, alias Raul Damonte, con la sua compagnia di donne, formiche, farfalle, cavalli e
fiori dispettosi) e rilevando che il progettista bresciano nelle sue illustrazioni abbracciò un gusto del paradosso caro alla tradizione umoristica
anglosassone. Se l’istitutrice altera richiama addirittura i personaggi del tedesco Wilhelm Busch, l’allergia al nozionismo e alle vessazioni
accende nella memoria la carica eversiva di Molesworth, geniale scolaro disegnato dall’inglese Ronald Searle che pubblicava anche sulla
“bibbia” del settore: il settimanale “Punch”, nato nel 1841.
Certi agganci si accendono nella mente dei cultori contemporanei dei fumetti, ma va tenuto presente che Fausto operò senza avere sott’oc-
chio certi colleghi di penna e matita. E se a qualcuno pare bizzarro che un uomo profondamente cattolico fosse dedito all’illustrazione
umoristica va ricordato quanto determinanti in Italia furono le pubblicazioni uscite su “Il Vitt” (prima “Il Vittorioso”) che fece conoscere
schiere di grandi fumettisti per decenni o, con una retromarcia di otto secoli, vanno rammentati gli originali schizzi di Albertano da Brescia
a margine delle sue opere.
Che Fasser sia un artista nel campo dell’illustrazione lo dimostra la sua capacità di sintesi, evidente nel volto di quel se stesso innamorato
che regge un aquilone a forma di cuore: lo sguardo che tremola e brilla, la piega di una borsa sotto l’occhio a dire le notti insonni, la linea
della bocca, perfetto tramite tra serietà e sorriso. Le invenzioni sono numerose, linguistiche e poetiche. Gonnellini scozzesi in defilé: a pal-
loncino, longuette o con frangia di pizzo sotto cravatte e baffoni. Il sol-leone non ride, come nei disegni naif, ma trasmette sarcasmo mostran-
do un naso indagatore di tutto rispetto, come quello del protagonista. Il soldato è la negazione del militarismo machista: in un disegno
guarda il foro della canna del fucile con inesperta ingenuità, in un altro dalla sua carabina spunta un fiore oppure il casco è troppo grande
per la testa del milite. Testa sulla quale si rovescia un mare d’inchiostro, lo strumento più congeniale a Fausto che, con la divisa, porta un
fiore gigante sulla spalla al posto dello schioppo: stupisce ogni volta che queste trovate siano precorritrici di quel pensiero controcorrente
sui “fiori nei cannoni” che in Italia conosceremo soprattutto nei ‘60-’70.
C’è un uomo-proiettile pronto a farsi lanciare verso la signorina Seassaro al di là della Manica mentre conta i giorni sul calendario, con la
rara delicatezza di un ragazzo che espone i suoi sentimenti, pure le lacrime. E tutta questa emotività produce un’immaginazione che dis-
torce le proporzioni degli oggetti, per farli diventare estensione dei nostri desideri: i personaggi si arrampicano su una pipa gigantesca o sul
cavallo degli scacchi, mentre un alter ego di F. progetta una casa che diventa espressione del suo stesso corpo. I libri sono meraviglia ma
non quando “lettura obbligata”: ecco i testi da far saltare con la dinamite o con il colpo di una colt, il fantino su un ippo-libro, i volumi con i
denti aguzzi e l’ometto che si deve mettere i paraocchi per studiare.
Perché il mondo è là fuori e il libro è visto sia come spauracchio che come riparo, oltre il quale si spalanca un altrove tutto da percorrere,
senza rinunciare ai sogni.
La dimensione onirica appare di continuo anticipando la bella avventura di “Achille”. L’innocenza frustrata dall’insipienza di chi sgrida e
domanda senza un perché accomuna alcune invenzioni giovanili ai disegni di fine anni Novanta, quando tra le carte di Fasser fece capolino
il nasone curioso di un fanciullo, cugino inconsapevole del Barnaby di Crockett Johnson. Un bambino che nella sua postura, nel suo mu-
oversi nello spazio, esprime tra mille paure una profonda fiducia nell’umanità, anche se “tutti contemporaneamente gli facevano domande
diverse e difficili”.
Tutta la corrente amorosa ed elettrica delle lettere avvolte in queste buste rimane per noi un segreto pressoché totale. Per questo è tanto
preziosa la polvere d’oro rimasta attaccata alle envelope spedite nel Berwickshire, a Londra o in viale Venezia a Brescia: allude a un mistero
anticipandone la grandezza, come fece quel cancellino affacciato sul “niente”, sull’immensità della natura, disegnato da Fasser in “Erano
gli orti”. Una porta di carta spalancata sulla libertà più dolcemente scatenata e fresca.
Sara Centenari
Vorrei essere una persona calma e riflessiva che non perde mai la pazienza.
Io non sono così. Mio marito mi capì subito, appena conosciuti. Io le cose le voglio fatte “ieri”. Non è una svista: intendo dire che fremo.
Voglio che progetti e problemi siano affrontati subito. Domani è già tardi, per me.
È presto spiegato il motivo delle buste disegnate che avvolgevano le 80 lettere di Fausto racchiuse in questo libro. Me le spedì quando avevo
17 anni, una al giorno, più o meno. Tutta l’immaginazione espressa a penna su quegli involucri sottili di carta, attraverso i mondi spalancati
dai suoi disegni, componeva una sorta di prefazione alla lettera. Dalla busta io sapevo già il suo umore e i suoi impegni: ammantava i suoi
scritti di una bellissima anteprima, per invogliarmi a leggerlo. Ero così impaziente di carattere che doveva inventarsi uno stratagemma per
attirarmi nella sua storia.
Le lettere mi raggiungevano in Scozia dove facevo la bambinaia “au pair”, la ragazza alla pari come si diceva: era il 1959. All’ultimo anno
di ragioneria avevo conosciuto una splendida professoressa di Edimburgo che era venuta a Gargnano, all’Università per stranieri: volai nel
Regno Unito per badare alla bimba di sua sorella. Tre mesi, un lungo periodo in cui io e il mio futuro marito ci trovammo così lontani, così
vicini.
Questa avventura ironico-romantica coinvolse, alla fine degli anni ‘50, vari postini e vicini di casa di Edimburgo e di Londra, ancor più
bramosi di me nell’attesa della posta giornaliera: la mia. Gli scambi erano coinvolgenti a tal punto che il porta-lettere mi incalzava: “Perché
oggi non ha ricevuto niente, signorina?”. “Si vede che era occupato”, rispondevo ridendo. Ci furono piccoli cortocircuiti di senso: scrissi
che avevo per amici dei “Guinea pigs”, porcellini d’India. Fausto fu attirato dalla parola “pigs” e la sua fantasia prese il volo. In risposta, a
decorare le buste, ecco le illustrazioni dei maiali con la penna da indiano e l’uomo in gonnellino: lasciarono di sasso il medico 65enne che
mi ospitava e che, in quanto scozzese, si risentì...
Sono accadute miriadi di cose da allora: avevo 17 anni a quel tempo e oggi la carta d’identità dice “80”, mentre Fausto non è più con noi
dal 2008. Sono vivi tanti ricordi, tra cui questa corrispondenza. Era visiva, artistica e prolifica pure quella tra mio marito e suo fratello Gigi,
architetto e pittore. E l’impulso originava dal loro stesso padre che nell’inverno 1917, durante la prima guerra mondiale, passò il Natale in
congedo per convalescenza e creò certe magnifiche scene, disegnate in un piccolo taccuino, che ripubblicammo anni fa. Il nonno Giovanni
Fasser illustrava le locandine per il Cai e il Touring mentre Gigi redigeva il giornale del liceo classico Arnaldo: era ed è ancora oggi
un’inclinazione viva in buona parte della famiglia.
Sorrido a questo fiore nella canna di fucile, a queste buste del periodo di leva con il soldato goffo e poetico: il mio futuro marito fu dichiarato
a un certo punto “inabile alle armi”. La prima volta che dovette premere il grilletto in esercitazione mancò poco che colpisse il suo amico!
Era incapace di sparare: le sue armi erano utensili pacifici, le matite.
Le lettere che mi arrivarono in collegio nacquero invece per praticità: la direttrice dell’istituto “Agli Angeli” non voleva che nessuno avesse
uno scambio epistolare con le collegiali. Allora Fausto mi inviò i disegni. Venivo comunque chiamata in direzione ma i messaggi passavano,
perché non erano testi scritti. Lui ritrasse perfino l’arcigna direttrice, con in mano una busta sospetta!
Le scene illustrate mi descrivevano la sua giornata e mi anticipavano che il suo treno sarebbe arrivato da Milano o da Genova il tal giorno.
Io mi facevo trovare in stazione.
Scambi immediati e visivi tra noi, perché “fatta la legge, fatto l’inganno”: io davo la mia risposta alle ragazze che non erano interne al collegio
e loro la spedivano per me.
Perché tante “vignette” ritraggono Fausto oppresso dai libri, dai muri, dagli impegni universitari? Perché li visse veramente come incubi:
un fumetto diceva persino: “Non è ver che sia la morte il peggior di tutti i mali” e si riferiva allo studio accademico. Aveva detto che dopo
l’università non avrebbe più fatto nemmeno l’esame del sangue!
Soffriva la costrizione, amava la leggerezza delle scelte appassionate. Fu una sua scelta quella di Ingegneria, non un’imposizione dei gen-
itori: ha lavorato bene, ha avuto molte soddisfazioni e ha creato un legame forte con suo fratello Gigi. Una coppia creativa che è durata a
lungo e che collaborò per la trasformazione del complesso di Santa Giulia. Me lo ricordo bene cosa significò quel lavoro: Fausto “sollevò”
una casa, nel punto in cui poi fu collocata la biglietteria del museo della città.
Noi ci sposammo nel 1963: io avevo 23 anni e lui allora lavorava in Sudan. In realtà non fu romanticissimo. “Sposati!” fu l’allarme, “sennò
non ci danno la casa, la assegnano a qualcun altro”. E così, dopo il certosino lavorìo delle buste e delle lettere racchiuse in questo libro, il
fidanzamento si trasformò in matrimonio al galoppo. Fummo velocissimi. Mia suocera, la nonna Gadola, non voleva che partissi – da non
sposata – per raggiungere Fausto in Africa, nel cantiere in cui lavorava. Queste nozze per procura furono un trauma per la mia famiglia,
soprattutto per mio papà che mi chiedeva: “E non avrai l’abito”? “No, cosa me ne faccio?”, gli rispondevo. “Ma non hai neanche il cappel-
lo...”. Allora il pomeriggio prima delle nozze uscii di corsa e andai da “Le parisienne” a prendermi un cappello blu con margherita bianca.
Indossai comunque un tailleur Chanel. Ma è vero: non ero vestita di bianco come una sposa. Fu tutto divertentissimo, però.
Fausto Fasser non era timido, era un uomo espansivo, fin troppo! Salutava ogni persona con entusiasmo. In Sudan divenne il perno di tutto
e ideò ovviamente il giornalino del cantiere, così come quello per la parrocchia o gli scout. Lui sapeva sempre coinvolgere un gruppo di
persone attorno a un progetto.
Mentre io studiavo nel mio salotto, da adolescente, lui scolpiva nel legno le figure degli scacchi: stava sempre creando o disegnando qualcosa.
Usciva con matita e libretto. Abbiamo avuto una vita movimentata: ci comprammo la casetta di Vione, quando scemò il frastuono dei quattro
figli - Maria Paola, Francesca, Giovanna e Filippo, venuti alla luce in un lustro - e costruimmo una piccola oasi di pace che anche adesso
è un nido per la nostra famiglia. Lui ogni mattina usciva col taccuino e, senza fotografare, tratteggiava le case, le chiese, gli alberi e gli orti
della cittadina in Valcamonica.
Dipinse quadri solo fino alla fine degli anni Cinquanta: forse, mi chiedo, perché gli è toccata una moglie molto critica? Lui, per fortuna, ha
sempre disegnato.
Nicoletta Seassaro
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
cara-signorina-buste-opt
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search